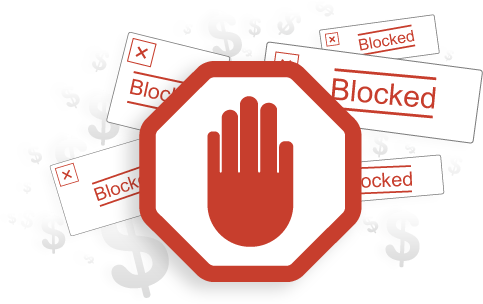Raffaele Schettino
Maria ha un aspetto materno che fa tenerezza. Abita appena fuori da Oświęcim e ogni giorno prende per mano due gruppi di visitatori italiani per accompagnarli nel santuario del dolore. Ha la voce calda e le parole le vengono fuori lente. Spesso, in segno di rispetto, china la testa e resta in silenzio. Lo fa davanti alle valigie e alle scarpe al di là dei vetri delle teche, lo fa davanti alla montagna di capelli che i tedeschi tagliarono alle donne prima di infilarli nelle balle già vendute a peso alle aziende che ne facevano coperte.
«La fabbrica della morte funzionava nel pieno rispetto della legge», dice con un filo di voce la guida di Auschwitz. La sua frase è un pugno nello stomaco che porta la mente oltre l’orrore, aggancia passato e presente, scopre un futuro preoccupante.
Anche adesso, in nome di leggi esistenti o in cantiere, c’è chi discrimina, odia, emargina, erige muri di ignoranza e intolleranza. E l’Italia non è esente dai pericoli di un sovranismo inquietante che rischia di far riaffiorare quel difetto endemico di cui parlava anche Mussolini. «Il fascismo non l’ho creato io, l’ho tratto dall’inconscio degli italiani», diceva.
All’interno dei recinti spinati dei campi di Auschwitz i deportati morivano secondo l’orribile legge alla base del credo nazista. Non solo per la pazzia di Hitler, ma anche per la convinzione folle dei medici votati ai principi dell’ eugenetica che stabilivano scientificamente le differenze tra la razza pura e i subumani, le diversità tra gli ariani e le vite indegne di essere vissute.
L’orrore era regolato dalla legge. Nel blocco 11, cioè nella prigione dentro la prigione, c’erano anche i riscaldamenti per i detenuti, anche se venivano accesi d’estate e spenti d’inverno. Nel campo di Auschwitz II, cioè Birkenau, per legge i nazisti avevano previsto addirittura vasche antincendio a tutela delle baracche di legno, anche se l’unica cosa che bruciava ai confini del bosco erano migliaia di corpi, scrigni di sogni e anime che ancora sembra sentire quando s’alza un alito di vento.
Maria, avvolta nel suo foulard azzurro, racconta storie di uomini e donne nei campi polacchi. Le sofferenze della gemellina che sembra fissare il corridoio dalla foto sulla parete, la malvagità dei medici che provarono a cambiarle il colore delle pupille con soluzioni chimiche. Racconta i segreti nascosti nell’unico vagone merci che oggi è fermo sulle rotaie di Birkenau, lo ha ricomprato otto anni fa da un deportato che ci aveva viaggiato da bambino, stretto alla mano del suo papà che fu trucidato sotto i suoi occhi appena arrivati all’inferno. E racconta di una donna che campeggia all’ingresso di un blocco, fotografata nel tragitto verso le camere a gas co un un bambino in braccio e un altro aggrappato alla sua gonna. Subumana lei, subumani i suoi piccoli, secondo i tedeschi.
Racconta e prega ogni visitatore di ricordare. Perché è questo il dovere di chi arriva ad Oświęcim. «Coltivare la Memoria». «Trasferirla ai giovani». Perché, dice Maria sottovoce,«quando non ci sarà più questo fiume di gente a calpestare i viali di Auschwitz, allora sarà tutto dimenticato, e i mostri del passato torneranno senza alcuna preoccupazione».
Sembra impossibile che il santuario dell’Olocausto possa svuotarsi dei suoi due milioni e mezzo di visitatori all’anno, eppure qualche pericolosa crepa s’è aperta sul futuro. Qualcuna la si nota sulla facciata del blocco 21, di fronte al cortile della prigione in fondo al quale si staglia il muro delle fucilazioni. Al tempo in cui i tedeschi trasformarono questa gigantesca caserma polacca nella fabbrica della morte più tremenda che sia stata mai concepita, quel blocco ospitava l’ospedale degli orrori, e nel giardino si ammassavano cadaveri e cavie che i prigionieri raccoglievano ogni giorno sui carretti da spingere fino ai forni.
Nel 1980, il blocco fu affidato all’Italia perché allestisse il padiglione della memoria in onore dei deportati caduti. Dentro ci misero un’opera d’arte e una mostra alla quale contribuì anche Primo Levi. Trentotto anni dopo non c’è più nulla. L’ Italia l’ha ritirata, come racconta Maria. E ad Auschwitz non c’è più traccia dell’Olocausto italiano. Nel 2007 il governo Prodi stanziò 900 mila euro per ripensare l’allestimento, ma la burocrazia elefantiaca del Belpaese e la scarsa attenzione sul tema, hanno reso possibile uno scempio morale che offende la memoria di 8.500 vittime italiane della Shoah.
«Non chiedeteci perché il blocco è vuoto a differenza di quelli assegnati agli altri Paesi», dice la guida indicando il padiglione di Francia, Belgio, Olanda. «Nessuno di noi addetti al museo se lo spiega. E pensare che qui è tutto gratis», persino le pulizie delle finestre dalle quali s’intravedono da sette anni pareti spoglie simbolo di un Paese che dimentica in fretta.
Non basta una sola visita ad Auschwitz, perché ci sono un mare di storie da ascoltare. Basta sedersi ai piedi degli edifici in mattoncini rossi che sanno ancora di morte e sofferenze indicibili: i pensieri si accavallano e la storia parla.
La piazza dell’appello, la forca, i forni, le garitte dei soldati che ancora sembrano spiare chi calpesta l’orrore. Il filo spinato. Nel silenzio ci si convince che Auschwitz e Birkenau dovrebbero essere tappe “didattiche” obbligatorie per le scuole italiane, come avviene per molti istituti polacchi. Perché qui si diventa più umani. Soprattutto, come dice la guida coi capelli bianchi, «si diventa più rispettosi della memoria».
Una parola che ripete fino alla noia. Del resto, senza memoria le lettere in ferro che compongono la scritta «Arbeit macht frei», non stringerebbero lo stomaco. «Il lavoro rende liberi» diventerebbe uno slogan da t-shirt. Senza memoria, Auschwitz sarebbe semplicemente Oświęcim, un puntino su Google maps tra linee ferrate e immense distese di terra e alberi. Nessuno saprebbe che qui, quando si scava, la terra continua ancora a riconsegnare le ceneri degli uomini passati per i camini dei nazisti mentre l’orchestra suonava beffarda all’ingresso del campo.
Ma la cultura della memoria purtroppo non è un valore acquisito. Non è scontata. E’ una ricchezza minata in ogni angolo del mondo, Italia compresa. Da noi la rivoluzione populista e sovranista continua a cavalcare la rabbia e la paura, continua a spingere per cambiare le regole fondamentali della costituzione. Mette in discussione la libertà di stampa, punta a cancellare le istituzioni democratiche. Spinge un gravissimo processo di analfabetizzazione dei giovani, insiste su un pericoloso esperimento di annientamento dell’opinione pubblica, e sul terribile progetto di appiattimento delle coscienze critiche limate a colpi di post rancorosi e carichi di odio.
Il campanello d’allarme suona ogni giorno, e lo ha voluto ricordare anche Liliana Segre, senatrice a vita nominata dal presidente Sergio Mattarella, una delle poche bambine uscite vive da Auschwitz.
Il suo monito arriva davanti a migliaia di studenti di una Genova ancora dilaniata dal dolore del crollo, dove si discute inevitabilmente delle regole che scandiranno i nuovi esami di maturità, e di conseguenza influenzeranno i programmi didattici di quest’anno. A dispetto dell’importanza della memoria, il ministero dell’Istruzione di questo illuminante governo gialloverde, ha scelto di abolire la traccia di storia. E per Segre è uno schiaffo in pienbo viso.
«Mi fa molta paura che abbiano tolto la storia dall’esame di maturità, perché non si diventa uomini senza sapere quello che è successo prima. Perché è un piccolo passo per dimenticare». E mentre lei parla, le crepe sul futuro appaiono più nette ancora, e assumono più forza anche le parole della guida coi capelli bianchi che implora a tutti i visitatori di Auschwitz di ricordare quanta malvagità può annidarsi nel cuore di un uomo.
«Un libro che consiglio agli studenti è 1984 di Orwell», dice Liliana Segre, «dove la storia cambiava a seconda di chi c’era il governo. Ecco: la mia grande paura è che la memoria, con la morte degli ultimi testimoni diretti e con quella dei carnefici, possa diventare una riga in un libro di storia. Lo temo molto: temo che si venga dimenticati e poi negati, o peggio: cancellati. Come il mare quando affonda il barcone: l’acqua si chiude e muoiono le persone».
Un messaggio chiaro e deciso a chi avrebbe la responsabilità di governare un Paese difficile in un momento tremendamente complicato, senza alzare i toni, senza esasperazioni, senza cercare lo scontro e senza creare nemici da gettare in pasto al popolo arrabbiato. Gli avversari politici. I giornalisti. I migranti. E a proposito, dice Segre: «Io lo so quello che si prova, perché lo avevo vissuto sulla mia pelle: sono stata una richiedente asilo rimandata indietro. Sono stata clandestina, manodopera minorile e schiava».
Forte della sua memoria, Segre si rivolge ai ragazzi: «Non odiate, smettete di utilizzare il linguaggio dell’odio a tutti i livelli, abbiate la coscienza della vostra forza e scegliete senza delegare. Sarebbe troppo facile dire che ci sono delle derive, ma io sono ottimista e voglio sperare che gli orrori del passato non si debbano ripetere mai».
Lei ha vissuto dentro quell’inferno che ancora oggi Maria continua a raccontare ogni giorno ai visitatori italiani. Racconta gli stessi orrori. Di quando un’infermiera oscena le tagliò un ascesso sotto l’ascella senza anestesia, con un paio di forbici, e che quando rientrò nella baracca una donna le donò tutto ciò che possedeva, una fettina di carota cruda nascosta in un panno sudicio. Le sembrò il dono più grande in quelle condizioni infernali di privazione, segno che l’amore resiste anche davanti alle barbarie dell’uomo.
«Sono la stessa bambina che a 8 anni s’è vista chiudere in faccia la porta di scuola solo per la colpa di essere nata. E anche se mi hanno aperto le porte del Senato, io sarò sempre quella bambina, perché quella porta chiusa non la dimenticherò mai». E non dimenticherà mai l’odore acre della morte che piombava sui pigiami a righe nei campi di concentramento. «Qui l’uomo ha provato a cancellare Dio, e non c’è riuscito», dice la guida alla fine della visita. «Non permettete che qualcuno cancelli la storia e la memoria».