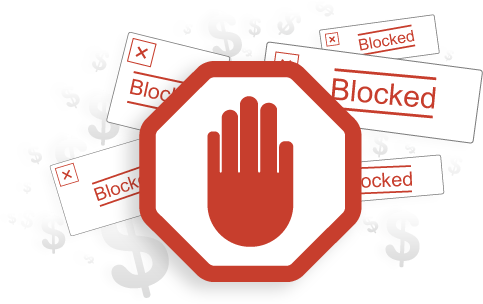L’omaggio a Siani di un mondo che calpesta il giornalismo
Il nome di Giancarlo Siani risuona nei discorsi istituzionali, riecheggia nelle cerimonie e nei convegni, campeggia sulle targhe commemorative, eppure si avverte la triste sensazione che la memoria sia completamente svuotata, che sia una liturgia rassicurante ma posticcia, un alibi collettivo per sentirsi «dalla parte giusta».
E allora, l’ipocrisia prende il sopravvento sulla necessità di fare i conti con la propria coscienza. Si commemora Siani ma si calpestano i valori del giornalismo per i quali Siani è morto. E allora viene da chiedersi: che senso ha coltivare la memoria di un cronista ucciso se si continua a calpestare il giornalismo? Se si fa di tutto per marginalizzarlo, delegittimarlo e intimidirlo?
In questo paradosso ormai strutturale, si arriva a commemora chi è morto facendo informazione libera, e intanto si tollera, o addirittura si alimenta, un clima di odio in cui chi cerca di fare informazione libera viene isolato o messo a tacere, magari con mezzi più eleganti, ma non meno efficaci.
Non è questione di percezioni. Sono i dati a dirlo.
Nel 2024, l’osservatorio Ossigeno per l’Informazione ha registrato 516 episodi di minacce e intimidazioni contro giornalisti e operatori dell’informazione in Italia. Dall’inizio del monitoraggio, avviato nel 2006, i casi documentati sono oltre 7.500. In media, più di un giornalista al giorno viene intimidito. Di questi, il 22% sono vittime di attacchi legali pretestuosi, di querele civili o penali usate non per ottenere giustizia, ma per zittire, logorare e intimidire. E in molti casi, anche quando l’esito finale è favorevole al cronista, il danno – economico, psicologico, reputazionale – è già fatto.
Ci sono giornalisti che vivono sotto scorta. Altri sotto vigilanza. Nel 2025, secondo la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, oltre 250 cronisti risultano sotto tutela in Italia. Alcuni perché minacciati dalla criminalità organizzata. Altri per aver documentato traffici, corruzione, collusioni tra politica e poteri opachi. Le cause civili contro i giornalisti si contano a migliaia. Sono novemila all’anno, più o meno. Venticinque al giorno. Non tutte infondate, ci mancherebbe. Ma una parte significativa ha la chiara funzione di scoraggiare. Le cifre raccolte prima della pandemia raccontano di 54.000 procedimenti in sei anni, e in molti casi le sentenze cervellotiche finiscono per mettere in discussione la libertà di stampa e il diritto di cronaca. Nel mondo, il quadro è altrettanto allarmante: nel corso del 2025, sono stati incarcerati 567 operatori dei media, 532 dei quali giornalisti, secondo «Reporters sans frontières». Senza contare i cronisti uccisi al fronte.
Ma la privazione della libertà non è sempre necessaria per colpire il giornalismo. Basta minarne la credibilità, e il gioco è fatto. Basta la diffamazione, l’isolamento, l’indifferenza. Basta coltivare tutti i sentimenti di odio che incidono sulla cultura pubblica che muta sulla base delle narrazioni demagogiche e populiste. Un clima di odio che poi divampa facilmente sui social media. Oggi, il giornalista è visto sempre più spesso come un nemico, un «servo dei poteri», un «venduto». Vittima di una retorica alimentata da chi, da anni, punta a disinnescare il ruolo critico della stampa, presentandola come casta, lobby autoreferenziale. Il risultato è che l’informazione viene spinta ai margini, e il vuoto viene colmato da monologhi autoprodotti, influencer politici, agenzie della verità improvvisate.
Anche le istituzioni ci mettono del loro. Le conferenze stampa sono sempre più rare, le domande sempre meno gradite, il controllo dei contenuti diventa più importante del contenuto stesso. Chi detiene il potere, invece di essere trasparente, preferisce essere opaco: meno accesso agli atti, meno libertà di documentazione, più filtri tra la realtà e chi la racconta. L’ipocrisia sta qui. Non tanto nel ricordo in sé di Giancarlo Siani, ma nell’uso politico, retorico, assolutorio che si fa della memoria. Come se bastasse pronunciare il un nome per ripulirsi la coscienza. Come se l’omaggio simbolico potesse compensare il silenzio reale.
Invece no. Difendere il giornalismo e la memoria dei suoi caduti dovrebbe essere un atto politico. Dovrebbe spingere a dotare chi fa questo mestiere di strumenti di tutela efficaci. Dovrebbe significare educare i cittadini a riconoscere il valore e l’importanza del lavoro giornalistico.Pretendere che le istituzioni restino il più possibile trasparenti, che l’informazione non sia filtrata, che l’accesso ai dati pubblici sia reale e immediato. Significa accettare che il giornalismo non è lì per compiacere, ma per disturbare. Che bisogna smetterla di asserire che esiste giornalismo e giornalismo, perché a quel vuol dire che qualcuno può arrogarsi il diritto di elencare i buoni e i cattivi.
Giancarlo Siani è morto perché amava il giornalismo e i suoi principi, perché faceva domande che davano fastidio. Oggi, chi continua a farle spesso viene ridotto al silenzio e all’emarginazione, non necessariamente con la violenza, ma con l’indifferenza. Ma il risultato è lo stesso: meno verità. Meno vigilanza. Più potere opaco.Per rendere omaggio a Siani, dunque, non basta un’altra commemorazione vuota. Serve una scelta di campo che valga anche domani e ogni giorno successivo. Perché o si è dalla parte del giornalismo o si è dalla parte del silenzio. Non c’è terza via.