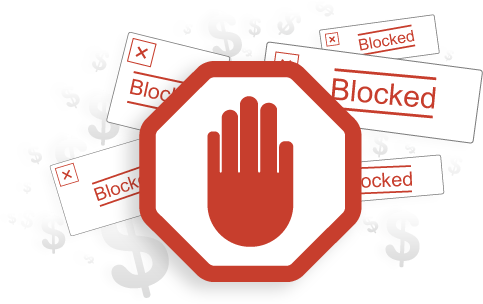James Senese, lo scugnizzo nero che spazzò via i pregiudizi con un sax
- Figlio della guerra
- L’incontro con il sax
- Gli Showmen
- L’omaggio a ‘O Nonno Mio
- James e Pino Daniele
- Quell’estate che cambiò tutto
- Il rapporto con Roberto De Simone
- «Chest nun è ‘a terra mia». Il testamento malinconico
- Un miracolo irripetibile
Il sax di James Senese non suona più. Una voce ruvida, profonda, viscerale. Una voce di Napoli che per decenni ha raccontato la rabbia e la grazia di un uomo «nero a metà» e di una città alla perenne ricerca del riscatto. Ogni nota portava con sé il rumore dei vicoli, il calore del Mediterraneo, la dignità di chi non si è mai arreso. Con la voce unica del suo sax, James Senese ha trasformato la sua storia in musica e quella musica è diventata il segno identitario che abbraccia storia e futuro. Diceva di sé: «Io sono figlio di un soldato americano nero e di una donna napoletana. Non sapevo chi fossi, poi ho capito: sono entrambi. Sono il suono di due mondi. Mi chiamavano “’o nir”, e pensavano fosse un insulto. Io l’ho trasformato in orgoglio, in ritmo, in vita, essere nero, per me, è portare dentro una storia di dolore e di luce. Io sono un nero napoletano. E questo non è un problema: è la mia verità. È sapere che la pelle parla, anche quando stai zitto. Io sono un napoletano nero. Sono figlio del sangue e del mare».
Figlio della guerra
Napoli, 1945. In una città che ancora ribolliva dalle bombe della guerra nacque, da una madre napoletana e da un soldato afroamericano della Buffalo Soldier Division, James Senese. Il padre, tornato negli Stati Uniti, non lo conobbe mai. James crebbe nel quartiere di Miano, tra i vicoli e la povertà di un dopoguerra senza indulgenze. Essere “nero a metà” nella Napoli degli anni Cinquanta non fu facile. «Mi guardavo e vedevo che non ero come gli altri. ‘Si’ nnire’, sei nero, questo era.» A scuola lo chiamavano “o niro”, per strada gli gridavano dietro. Ma accanto a lui ci fu un angelo: nonno Gaetano, pittore e restauratore di chiese, che gli insegnò l’orgoglio e la dignità. La canzone Tammurriata nera, che raccontava di un figlio nato da un soldato nero e una donna napoletana, gli rimase addosso per sempre. «Era una canzone razzista – diceva – perché raccontava di me, ma nel modo sbagliato». Eppure, come la città, anche lui trasformò il dolore in ritmo. Napoli, con tutte le sue contraddizioni, divenne il teatro del suo riscatto.
L’incontro con il sax
Un giorno, la madre tornò a casa con la copertina di un disco. Sopra, un uomo di colore con un oggetto lucente tra le mani: era John Coltrane. «Guarda, Jé, è come tuo padre», gli disse. Quel gesto semplice accese un fuoco. James osservò quell’uomo e vide, per la prima volta, un padre, un’identità, un futuro possibile. Supplicò la madre di comprargli uno strumento identico. Lei, tra mille sacrifici, gli comprò un sax soprano. Da quel giorno, non se ne separò mai. «Grazie alla musica non mi difesi più con i cazzotti, ma con le note del mio sax». A dodici anni, James aveva già capito tutto: la musica era la sua arma, la sua salvezza, la sua voce. La musica era democratica, non guardava il colore o la ricchezza. Fu la lingua universale con cui James decise di raccontare il suo mondo.
Gli Showmen
La musica di James Senese nacque tra le strade di Napoli dei primi anni Sessanta, tra il brusio dei vicoli e il suono dei mercati. Insieme a Mario Musella e ad altri giovani musicisti, formò i primi complessi locali, e già allora il suo sax cominciò a parlare con voce decisa, intensa e autentica. La svolta arrivò con “The Showmen”, un gruppo che unì il soul e il rhythm & blues americano con il calore e l’ironia della città. Le cover di Otis Redding, James Brown e Marvin Gaye si alternarono a brani originali come “Un’ora sola ti vorrei”, che trionfò al Cantagiro del 1968. Il pubblico li ascoltò, li applaudì, si riconobbe in quel suono familiare e rivoluzionario. Fu l’inizio di un sogno che parve impossibile eppure già palpabile. Quando gli Showmen si sciolsero, James non si fermò. Con Franco Del Prete diede vita prima agli Showmen 2 e, nel 1974, alla creatura destinata a segnare per sempre la sua carriera: “Napoli Centrale”. Fu lì che il suo sax trovò davvero la propria voce: un linguaggio che mescolò jazz, rock e dialetto napoletano, una forma espressiva inedita che raccontò la città popolare con la forza della sua rabbia e della sua verità. Il singolo “Campagna” e l’album omonimo del 1975 segnarono l’inizio di un’avventura lunga decenni. «Il segreto – raccontava James – fu l’alchimia che si instaurò tra noi: un americano, un inglese e due napoletani. Napoli Centrale nacque da quella chimica, in modo naturale, senza calcoli, senza paura. Ed è lì che tutto ebbe senso.» La band divenne presto uno dei pilastri del Neapolitan Power, il movimento che negli anni Settanta e Ottanta rivoluzionò la musica italiana, fondendo le radici partenopee con il jazz, il funk, il soul e le sonorità mediterranee. Senese e i suoi compagni non inventarono solo canzoni: inventarono un linguaggio musicale, un modo nuovo di raccontare Napoli, la sua gente, la sua vita.
L’omaggio a ‘O Nonno Mio
Nel loro album Mattanza, Napoli Centrale include il brano ’O nonno mio’ che è una dichiarazione d’amore verso il nonno. «Mio fratello d’anima, Franco Del Prete, ha messo in musica esattamente quello che io provavo. Io mi chiamo Gaetano, come il mio nonno, un nome comune dalle nostre parti, ma carico di significato: Gaetano è il santo patrono di Miano, per noi importante quanto San Gennaro o San Ciro a Portici. Mio nonno era pittore, modellista, restauratore nelle chiese, e faceva il suo lavoro con amore, passione e umiltà. Era piccolo di statura, ma grande in tutto. Quando in strada mi prendevano in giro, lui correva a difendermi e poi mi abbracciava, sussurrandomi: “Jè, nun dà retta a nisciuno, tu sì speciale e io sarò sempre vicino a te a ricordartelo…”. Avevo solo dieci anni quando se ne andò. Da lì nacquero pezzi come Campagna, A gente ’e Bucciano, Malasorte, ’O nonno mio. Franco Del Prete, batterista straordinario e compagno di vita, fu al mio fianco in questo viaggio. Napoli Centrale nasceva dall’ispirazione dei cartelli della stazione ferroviaria e dall’urgenza di contaminare le melodie napoletane con le influenze afroamericane, creando quel movimento che oggi chiamiamo Napolitan Power. Eravamo una combriccola di musicisti innamorati del sound statunitense. “Che roba sunamm”? Nuje facimm o jazz. Lo cantiamo in napoletano perché la nostra lingua è intrinsecamente blues. Con Napoli Centrale siamo stati all’avanguardia, aprendo la strada a tanti, incluso Pino Daniele, il migliore di tutti, un fratello vero».
James e Pino
Un pomeriggio, Pino Daniele andò da James. Era grande, goffo, simpatico. James lo ricordò con un sorriso: «Mi piacque subito. Mi colpì il suo entusiasmo, il suo amore per la musica, la sua napoletanità verace, mai eccessiva o sguaiata. Da quel giorno ebbi un fratello più piccolo». Fu proprio James a scoprire il talento di Pino e a trascinarlo dentro il progetto Napoli Centrale. Da allora, tra i due nacque un legame profondo, umano e artistico, destinato a cambiare per sempre la musica italiana. Quando Senese incontrò Pino, la musica napoletana cambiò direzione. I due non si limitarono a suonare insieme: inventarono un linguaggio nuovo, che unì la tradizione partenopea al funk, al blues, al rock e al jazz. James portò il ritmo delle periferie e il linguaggio del jazz; Pino portò la melodia e la poesia, la capacità di fondere il blues americano con la canzone napoletana. «Con Pino,» raccontava James, «in maniera naturale, cantammo e suonammo una nuova Napoli. Lui scriveva le canzoni e noi pittavamo la sua tela con i nostri strumenti. Una cosa irripetibile… o se ne nascerà un’altra, sarà tra tremila anni». Fu l’inizio di una rivoluzione musicale che trovò la sua piena espressione pochi anni dopo con l’album Nero a metà e con il leggendario concerto in Piazza del Plebiscito. La sera del 19 settembre 1981, Napoli visse uno dei concerti più belli e indimenticabili della sua storia. Decine di migliaia di persone riempirono la piazza per cantare insieme a Pino Daniele. Sul palco, accanto a lui, ci furono i suoi fratelli di sempre: James Senese al sax, Tullio De Piscopo alla batteria, Tony Esposito alle percussioni, Joe Amoruso alle tastiere e Rino Zurzolo al basso. Per James, non fu solo un concerto. Fu il coronamento di un sogno collettivo: quello di una generazione di musicisti che aveva creduto nella forza della propria identità e nella possibilità di fondere mondi diversi: il jazz e la tammurriata, il funk e la poesia, il blues e il dialetto. «Non dovevo dire niente,» ricordava, «bastava suonare. La piazza rispondeva, Pino mi guardava e ci capivamo al volo». Quella notte, il sax di James e la chitarra di Pino parlarono la lingua di una città intera: Napoli, finalmente libera di raccontarsi attraverso la propria musica.
Un’estate che cambiò tutto
Negli anni, il sassofono di James Senese si intrecciò con i più grandi. Suonò con Gil Evans, Ornette Coleman, Lester Bowie, con l’Art Ensemble of Chicago. E poi con Bob Marley, là dove la musica non ebbe più confini. La sua carriera lo portò lontano, fino al mitico Apollo Theater di New York, dove lo chiamarono “Brother in soul”. Fu l’anima nera di Napoli che parlò al mondo intero. Era il 27 giugno 1980 quando Bob Marley salì sul palco di San Siro. Prima di lui, a scaldare quella marea umana, ci fu un giovane Pino Daniele. Due artisti che, senza saperlo, scrissero una pagina di storia. Due uomini diversi eppure simili: entrambi figli del mare, entrambi nati dal dolore e dalla speranza. Il tour fu quello di “Nero a metà”, il disco che molti avrebbero poi chiamato capolavoro. Quando la band arrivò a San Siro, viaggiava in uno stato di grazia assoluta. «Eravamo come una famiglia, un corpo solo, io, Pino e gli altri. Tutto passò, ma quello fu un momento di magia», ricordò Senese. Le note si alzarono, il sax di Senese divenne voce, la chitarra di Pino pianse e rise, e nell’eco lontano del reggae di Marley sembrò che il mondo, per un istante, respirasse all’unisono. Fu un concerto immenso, un incontro di anime. Napoli e Kingston si parlarono attraverso il ritmo. Il sud e il soul si riconobbero fratelli. James, Pino e Bob: tre destini intrecciati dalla stessa fiamma. Tre uomini che suonarono per sopravvivere, per amare, per dire al mondo che la musica fu vita, fu riscatto, fu preghiera. In quell’estate lontana, sotto il cielo acceso di Milano, il suono non fu solo suono. Fu magia. Fu leggenda.
Il rapporto con Roberto De Simone
Il legame tra James Senese e Roberto De Simone era profondo e complesso, segnato da una grande stima e da una comune visione del mondo artistico. James parlava spesso del maestro con affetto e con un pizzico di amarezza, ricordando come entrambi fossero figure fuori dagli schemi, spesso poco comprese dal sistema culturale italiano. «Anche De Simone, in qualche modo, era bullizzato come me, anche se per motivi diversi», raccontava James. «Lui era un genio, troppo genio per chi comandava e muoveva i fili del sistema. A De Simone lo avevano metaforicamente già seppellito anni fa. Avevano deciso che il re doveva morire. Non era mai stato supportato come avrebbe meritato. L’avevano fatt’ for’, quando invece avrebbero dovuto dargli le chiavi del San Carlo e del Conservatorio.» Nelle sue parole traspariva una profonda critica verso l’ambiente culturale che spesso ignorava i veri talenti. «Ora tutti parlano di lui, come hanno fatto con Totò, con Pino: tutta gloria post mortem. Dopo tutti sono pronti a salire sul carro del morto, come maruzze che escono dal guscio, pronti a dire “era ’o meglio amico mio”, “con lui ho fatto… ho detto…”, anche quelli che non ci sono mai stati. Ora erano tutti amici di Roberto come ora erano tutti amici di Pino…» Con il maestro De Simone, Senese aveva condiviso momenti artistici di grande intensità. La loro collaborazione iniziava nel 1985 con il Requiem di Natale e proseguiva con il Requiem per Pasolini nel 1986, presentato al Teatro San Carlo per quindici giorni consecutivi. «Roberto aveva chiamato all’inizio Pino, poi pensò a me, coinvolgendomi», ricordava James. «Trovavo difficoltà nella voce perché aveva composto le musiche su quella di Pinotto, ma riuscivo comunque a farcela. Era il 1986 e al San Carlo proponemmo il Requiem per Pasolini. Una cosa fantastica.» Senese raccontava spesso il suo primo incontro con l’orchestra del teatro. «I maestri d’orchestra, elegantissimi, impeccabili, mi guardavano con diffidenza, e io questa cosa la avvertivo. Feci un bel respiro, soffiando nel mio sax, allontanando qualsiasi timore.» Il Requiem per Pasolini rimaneva una delle esperienze più importanti della sua carriera. Per James, De Simone rappresentava un simbolo: un artista puro, libero, grande abbastanza da spaventare i mediocri. Le sue parole testimoniavano non solo l’ammirazione per il maestro, ma anche la consapevolezza amara di quanto il genio, in Italia, spesso venisse riconosciuto solo dopo la morte.
«Chest nun è ‘a terra mia». Il testamento malinconico
Il titolo dell’ultimo album di James Senese, Chest nun è ‘a terra mia (2023), non ha lasciato spazio a dubbi sul sentimento che attraversava l’artista in quel periodo. La musica sembra essersi fermata, i sentimenti si smarriscono, e i ragazzi non capiscono più niente: si affrontano per una scarpa calpestata, un parcheggio o uno sguardo di troppo. Da sempre James cercava di dare un senso alla realtà che lo circondava, ma descrivere la società contemporanea si rivelava sempre più difficile. «Chest è na società sott e ‘ngopp», osservava, indicando una realtà fragile, superficiale, dove tutto sembrava effimero e la lotta quotidiana faticava a trovare una direzione. Nei nove brani che compongono l’album, James ha provato a raccontare quell’umanità in conflitto con sé stessa, alla ricerca di risposte e verità. Ogni pezzo rappresenta un tentativo di farci confrontare con le emozioni più autentiche: solo abbracciando fino in fondo ciò che si prova si può comprendere davvero il senso della vita. L’album è intenso, viscerale, una testimonianza di una società che, nonostante il passare del tempo, sembra ripetere sempre gli stessi errori. In Chest nun è ‘a terra mia, il motivo musicale che accompagnava la frase del titolo si ripete ogni volta, come se volesse sottolineare la distanza tra la società che vorremmo e quella che troviamo davanti. Gli accordi minori e diminuiti, insieme al basso che ripeteva ciclicamente la stessa melodia, creano una tensione sonora che amplifica il messaggio, mentre la voce di James alterna sequenze furiose e palpitanti a momenti più intimisti e concilianti. Così lo stesso James ha introdotto il suo lavoro: «Siamo da sempre tutti contro tutti. lo lotto da quando sono nato, sembra che le cose siano cambiate in meglio, ma è falso.» Con queste parole invitava il pubblico a cercare le dimensioni più profonde del proprio io, a lasciarsi attraversare dai sentimenti più autentici e a trovare quella felicità che spesso sfuggiva. La musica diventa così non solo espressione artistica, ma anche strumento di resistenza e riflessione. La sua produzione riflette temi sociali e culturali profondamente legati a Napoli e alla sua gente: identità, emarginazione e riscatto restano sempre al centro dei suoi brani. Il suo sax inconfondibile raccontava emozioni complesse, tra dolore e forza, speranza e paura, guerra e resistenza. Rivolgendosi ai giovani musicisti, James offriva un consiglio chiaro: «Questo è un mestiere molto difficile, di grande sentimento. Bisogna crederci veramente per realizzare i propri sogni. Se non ci credi è meglio dedicarti ad altre cose».
Un miracolo irripetibile
Ma prima di sentirsi estraneo alla propria terra, James Senese visse Napoli come un laboratorio creativo senza confini, un luogo in cui la musica era respiro collettivo e alchimia tra amici. Fu qui che James incontrò Pino Daniele, con cui condivise scorribande musicali e sogni di un suono nuovo, capace di fondere jazz, blues e melodie napoletane. Insieme a loro, artisti come Enzo Gragnaniello, Tony Esposito, Tullio De Piscopo e i fratelli Bennato costruirono un mosaico sonoro unico, fatto di improvvisazioni, lunghe jam session e una complicità che trascendeva i generi. Quel laboratorio musicale era un modo di pensare la musica: aperta, popolare e colta allo stesso tempo. Ogni concerto un momento in cui le differenze si annullavano e la creatività esplodeva senza limiti. James portava il suo sax come un’estensione del corpo e dell’anima, e le sue note dialogavano con le chitarre di Daniele, i tamburi di De Piscopo, le voci graffianti di Gragnaniello e dei Bennato, creando un linguaggio comune che diventava immediatamente riconoscibile. Quella Napoli non era soltanto la città natale: era un laboratorio di vita, una scuola di umanità, in cui la musica insegnava la solidarietà, la libertà e la forza di reinventarsi. Erano giorni in cui il futuro sembrava possibile, in cui l’arte era un’arma di resistenza contro la superficialità e l’indifferenza. È proprio da quegli anni, da quella stagione di incontri e scoperte, che James Senese ha tratto la sua eredità artistica più preziosa. Anche oggi, mentre osserva una società che fatica a riconoscersi nella propria profondità, quella memoria musicale rimane viva: un monito, un conforto e un invito a ritrovare il senso della bellezza e dell’autenticità nella musica e nella vita. Con Chest nun è ‘a terra mia, James Senese non smette di interrogarsi e di interrogare il suo pubblico. La sua musica rimane un invito a osservare il mondo con occhi nuovi, ad aprire il cuore e a lasciarsi attraversare dai sentimenti più profondi, solo così si può comprendere davvero il senso della vita.