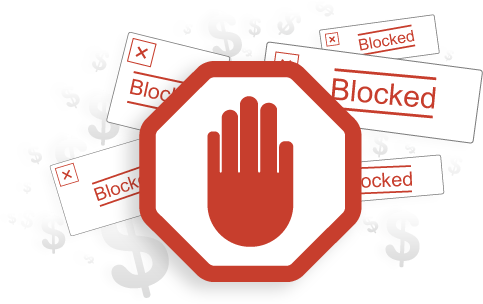Cinema. «L’uomo in più», il capolavoro d’esordio di Paolo Sorrentino
Nel 2001 Paolo Sorrentino era ancora un misconosciuto 31enne, che aveva lavorato a qualche cortometraggio e a una sceneggiatura. Napoli era diversa da oggi, ma un quarto di secolo fa si può dire che il mondo in generale stesse vivendo un’altra epoca, e sarebbe strano se fosse stato il contrario perché, con la velocità anche comunicativa alla quale ci siamo abituati dal secondo dopoguerra, venticinque anni sono tanti. Napoli era diversa, si diceva: non godeva della buona fama nelle cronache e, pur essendo sempre una città classica nel mondo, non era sovraesposta al turismo per come la leggiamo oggi. Tuttavia, però, ancora era da venire quelle frattura nella criminalità organizzata che appena qualche anno dopo l’avrebbe relegata, e per un periodo di tempo abbastanza lungo, ai soli notiziari “neri” del tempo. L’Italia invece era divisa essenzialmente tra chi sosteneva, amava o sopportava Berlusconi e tra chi lo odiava. Lui era al suo secondo mandato. L’Occidente era scosso dall’attentato dell’11 settembre, negli Stati Uniti c’era Bush figlio e a Londra Tony Blair; a Mosca Putin era ormai nel suo secondo anno di governo e mai la Russia era sembrata tanto vicina agli Stati Uniti, specialmente nel sostegno alla lotta al talebanismo, tanto che di lì a breve si sarebbe inaugurato un filone tutto hollywoodiano, dove i “villain” non erano più russi e nemmeno, come era stato per un decennio dopo la caduta dell’Unione Sovietica, qualche appartenente ai territori dell’ex impero nel Caucaso, ma piuttosto mediorientali, islamici fanatici, attentatori e quant’altro.
Gli altri premier europei di una certa levatura erano Jopsin, Aznar e Schroder. Ma il film di Sorrentino non c’entrava assolutamente nulla con tutto ciò, perché guardava a un’Italia di vent’anni prima, così come farebbe un film che uscisse oggi parlando del mondo che ho appena descritto, che pure certo secondo me è importante per capire in quale clima culturale e politico vennero lanciati Sorrentino e Servillo, due che ancora oggi riempiono le sale di tutto il mondo. Il film d’esordio di Paolo guarda a due personaggi che riecheggiano Franco Califano – impossibile che non si conosca un tale genio irregolare del cantautorato italiano – e Agostino Di Bartolomei, il grande capitano della Roma scudettata del 1983 che, una volta ritiratosi da un mondo infausto quale è quello del calcio, morì suicida. Essenzialmente sembra un film costruito – anzi lo è – sulle vite parallele e un po’ “plutarchiche”, potremmo dire, di due “falliti di successo”, se si vuole passare questo ossimoro romantico e letterario, non poco in voga negli anni. Che pure sono stati due uomini completamente diversi tra loro, quasi opposti, e così anche i personaggi, gli omonimi Antonio Pisapia che stanno nella pellicola cinematografica. Tanto è sgargiante, donnaiolo e prorompente l’uno, eccessivo, maledetto ed estroverso, tanto l’altro è ripiegato su sé stesso, introverso ai limiti del nichilismo, (o)scuro, quasi nascosto nel suo essere misterioso. “Il calcio è un gioco allegro”, gli dice il suo allenatore, “e tu sei fondamentalmente un uomo triste”; qui sta la chiave per interpretare quello che è, forse anche come film in sé, effettivamente “un gioco”: nonostante la tragicità della trama, del contesto, dei personaggi interpretati con verve opposta ma eguale efficacia da Tony Servillo e Andre Renzi. Ma nel contesto è un dramma permeato da un alone indefinito di “scherzo” grottesco, come se Sorrentino non volesse fare per forza davvero sul serio.
Come anche “Le conseguenze dell’amore” e via via parte del suo cinema, non si capisce dove finisca il dramma e dove inizi la farsa, tanto qui fa talvolta da controcanto alle immagini anche qualche frase buttata lì così, un po’ “Baci Perugina” e un po’ citazionismo boomer da social: “Nella vita non esiste il pareggio”, o anche “’’a vita è ‘na strunzata” e via discorrendo… La Napoli di inizio anni Ottanta è quasi assente o quantomeno non particolarmente presente, se pensiamo al peso che questa città riesce sempre ad avere nelle rappresentazioni artistiche. Ma alcuni scorci marittimi melanconici lasciano il segno. D’altra parte anche in alcune sue pellicole posteriori il vomerese sembra tenere fede alla sua provenienza e a rappresentare poi questo quartiere per quello che è, con scorci architettonici di condominii residenziali, borghesi, molto diversi dai bassi napoletani del centro storico (si veda specialmente “è stata la mano di Dio”. Le sequenze più dense e memorabili, io penso, sono anche quelle più tristi: Servillo che canta in qualche paesino abruzzese, davanti a poche persone, come a suggellare malinconicamente il funerale di sé stesso, dell’artista che è, fatto fuori da un codice comportamentale di un’Italia ancora benpensante e bigotta. Anche se è un film “doppio”, “binario”, scorre in maniera univoca, è narrativamente compatto e si fa ricordare per questo. Sorrentino ha dentro di sé ancora tutta la forza visionaria e la potenza del giovane esordiente, che ha tanto da dire e dare al mondo. Forse il suo più grande film?