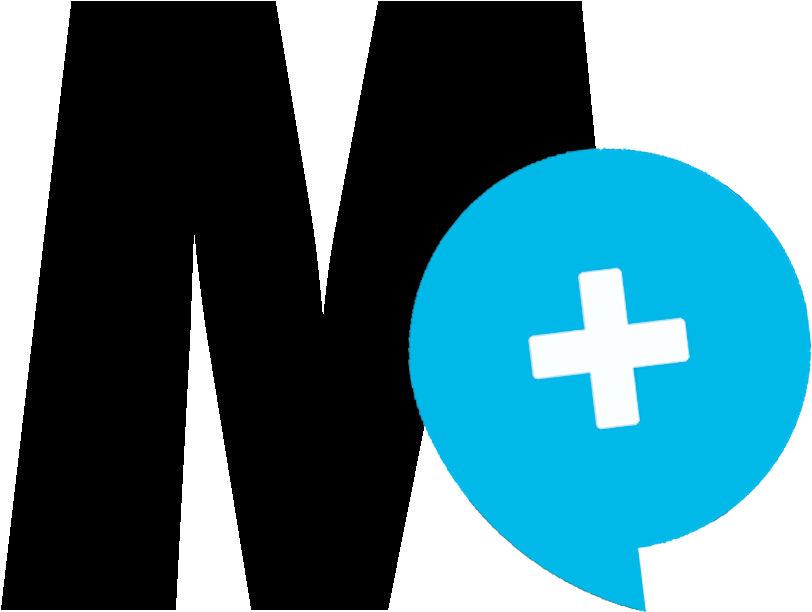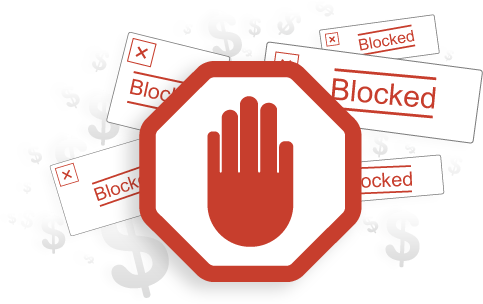La parola dell’anno: fiducia, bene fragile del nostro tempo
Una parola che più di tutte le altre ha attraversato questo intenso 2025 come un filo sottile e al tempo stesso resistente: «fiducia». Non a caso l’hanno indicata come parola di un anno che si chiude con l’amaro in bocca per le guerre, per le incertezze, per quella consapevolezza di un mondo che stenta a migliorare. Ed è proprio per questi sentimenti che la scelta della parola dell’anno, stavolta, pià che una celebrazione sembra essere una diagnosi. Le società non sentono il bisogno di nominare ciò che possiedono in abbondanza; nominano ciò che manca, ciò che si incrina, ciò che rischia di andare perduto. Parlare di fiducia oggi significa riconoscere una ferita aperta.
Cos’è la fiducia? La fiducia è un bene invisibile, e proprio per questo spesso sottovalutato. Non compare nei bilanci pubblici, non si misura nei parametri economici, non è immediatamente quantificabile. Eppure è ciò che tiene insieme le comunità, rende possibile la democrazia, tiene in piedi l’economia, consente alle persone di vivere non solo accanto, ma insieme. Quando la fiducia si ritrae, tutto resta in piedi, ma cambia natura: i rapporti diventano più rigidi, le regole più oppressive, la convivenza più sospettosa. Viviamo in un’epoca in cui la fiducia è sotto assedio da più fronti. Non per un singolo evento, ma per una convergenza di crisi: geopolitiche, tecnologiche, culturali, morali. È una sfiducia diffusa, strisciante, che non esplode in rivolte clamorose ma si deposita lentamente nel linguaggio, nei comportamenti, nelle aspettative reciproche.
La fiducia e la politica La politica è il primo grande luogo in cui la fiducia si è incrinata. Non perché le promesse non siano mai state tradite – la storia insegna che non è una novità – ma perché si è spezzato il nesso tra parola e responsabilità. La promessa politica ha perso peso, durata, conseguenze. Non genera più attesa, ma scetticismo; non mobilita, ma disincanta. La democrazia vive di un patto implicito: i cittadini accettano la delega perché confidano che chi governa agirà nell’interesse collettivo, o almeno ne renderà conto. Quando questa fiducia viene meno, la partecipazione si svuota, il voto diventa rituale, la politica scivola verso il marketing o il risentimento. Non è un caso che la sfiducia sia terreno fertile per il populismo: quando non si crede più nelle istituzioni, si è pronti a credere in chi promette scorciatoie. Ma la sfiducia politica non nasce solo dai palazzi del potere. È alimentata da una narrazione costante del fallimento, dall’idea che tutto sia corrotto, che nulla funzioni, che ogni tentativo di mediazione sia un tradimento. È una sfiducia che diventa identità, che si trasforma in cinismo. E il cinismo, più ancora dell’indignazione, è il vero nemico della democrazia.
Guerre: fabbriche di sfiducia Le guerre che segnano il nostro tempo non distruggono solo città e vite: erodono la fiducia come principio ordinatore del mondo. La guerra è il luogo in cui la menzogna diventa strategia, l’eccezione regola, la violenza linguaggio. In guerra non si chiede più “che cosa è vero”, ma “chi sto ascoltando”. È un cambiamento devastante, perché incrina l’idea stessa di verità condivisa. Le guerre contemporanee, amplificate dai media e dai social network, producono una polarizzazione radicale. Ogni conflitto genera tifoserie morali, narrazioni contrapposte, semplificazioni brutali. Chi prova a tenere insieme complessità e umanità viene accusato di ambiguità. Così la fiducia non solo si riduce, ma si radicalizza: si concede solo a chi appartiene al nostro campo. C’è poi un effetto più profondo: la guerra abitua alla paura. E la paura è incompatibile con la fiducia. Una società impaurita è una società che si chiude, che sospetta, che si difende prima ancora di capire. Anche quando i conflitti sembrano lontani, il loro impatto è globale: incrinano l’idea di futuro, rendono più fragile ogni progetto, spingono a vivere nel presente immediato. Senza futuro, la fiducia si atrofizza.
La fiducia e l’economia L’economia funziona perché milioni di persone compiono scelte basate su una fiducia implicita. Quando la fiducia vacilla, l’economia non crolla di colpo: rallenta, si irrigidisce, perde slancio. La fiducia è il capitale invisibile senza il quale nessun capitale reale può produrre effetti duraturi. Gli economisti lo sanno da tempo: senza fiducia non c’è investimento, senza investimento non c’è crescita, senza crescita aumenta la paura. È un circolo che può essere virtuoso o vizioso, e oggi rischia sempre più spesso di diventare il secondo. Il primo segnale della crisi di fiducia economica si manifesta nei comportamenti dei consumatori. Non è solo una questione di reddito o inflazione: è una questione di percezione del futuro. Con la prudenza l’economia si muove meno e la sfiducia trasforma il consumo in sopravvivenza. Anche le imprese risentono profondamente della sfiducia. Investire significa credere in un contesto prevedibile e, di conseguenza, creare opportunità di lavoro. Quando queste condizioni vengono meno, l’impresa si difende: riduce l’orizzonte temporale, privilegia il profitto immediato, rinuncia alla visione di lungo periodo. La sfiducia spinge verso una forma di capitalismo difensivo, meno innovativo e più concentrato sulla rendita. Non è un caso che nei contesti di bassa fiducia crescano le disuguaglianze: chi può permettersi di proteggersi lo fa, chi non può resta esposto.
Il rapporto Stato-cittadini La fiducia è centrale anche nel rapporto tra cittadini, mercati e Stato. Il debito pubblico, per esempio, non è solo una questione contabile: è una questione di credibilità. I mercati acquistano titoli perché confidano nella capacità di uno Stato di onorare i propri impegni. Ma anche i cittadini pagano le tasse perché credono che quelle risorse verranno utilizzate per il bene comune. Quando questa fiducia si rompe, tutto diventa più costoso: il debito, la burocrazia, il controllo. Lo Stato è costretto a moltiplicare le regole perché non può più contare sulla lealtà diffusa. È un’economia che funziona per costrizione, non per cooperazione. Globalizzazione La globalizzazione ha ampliato enormemente i mercati, ma ha anche messo sotto pressione la fiducia. Catene del valore lunghe, decisioni lontane, responsabilità diluite: tutto questo rende più difficile identificare chi risponde di cosa. La crisi finanziaria del 2008 ha segnato uno spartiacque proprio perché ha rivelato quanto fragile fosse la fiducia nel sistema. Da allora, una parte consistente dell’opinione pubblica ha smesso di credere che l’economia globale lavori per il bene di tutti. Questo ha alimentato protezionismi, chiusure, nazionalismi economici. Non sempre irrazionali, ma spesso guidati più dalla sfiducia che da un progetto alternativo.
Disuguaglianze e lavoro Le società più diseguali sono anche quelle con il più basso livello di fiducia interpersonale. È un dato che ritorna in molti studi: dove la distanza sociale è ampia, la cooperazione diminuisce. E senza cooperazione, lo sviluppo perde efficienza e legittimità. Il lavoro è forse il luogo in cui la fiducia economica si gioca in modo più concreto. Contratti precari, salari incerti, carriere discontinue minano la fiducia non solo nel mercato, ma nella propria vita. Chi non può progettare il futuro difficilmente investirà, consumerà, rischierà. La precarietà prolungata non produce flessibilità virtuosa, ma insicurezza strutturale. E l’insicurezza è nemica della fiducia. Un’economia che si regge su lavoratori sfiduciati è un’economia fragile, anche quando cresce.
Informazione e sfiducia Un altro fronte decisivo è quello dell’informazione. Mai come oggi siamo stati così informati e, paradossalmente, così incerti di ciò che leggiamo. La sovrabbondanza di notizie non ha prodotto maggiore chiarezza, ha generato una pericolosa stanchezza cognitiva che sta anche disincentivando i lettori. Il problema non è solo la diffusione delle fake news, che sono diventate un cancro difficile da estirpare, il problema è anche la perdita di gerarchie di credibilità. Quando tutto sembra opinione, quando ogni fonte è sospetta, quando l’esperto viene messo sullo stesso piano dell’improvvisatore, la fiducia si dissolve. Non perché si scelga consapevolmente di non credere, ma perché diventa troppo faticoso orientarsi. In questo vuoto si insinua la sfiducia generalizzata: nessuno è davvero affidabile, tutto è manipolazione. Il giornalismo, in questo contesto, ha una responsabilità enorme. Non può limitarsi a inseguire l’emergenza o l’indignazione del momento. Deve ricostruire fiducia attraverso rigore, trasparenza, ammissione degli errori. La fiducia non nasce dall’infallibilità, ma dalla coerenza.
La fiducia nel prossimo C’è però una dimensione ancora più delicata, spesso trascurata: la fiducia nel prossimo. Quella che regola i rapporti quotidiani, i gesti minimi, la convivenza ordinaria. È qui che la sfiducia si insinua con maggiore silenzio. Non viviamo in una società più violenta di altre epoche, ma in una società più diffidente. Il prossimo non è più automaticamente simile a noi: è un potenziale rischio, un concorrente, una minaccia. Questo sguardo altera profondamente il tessuto sociale. Tutto deve essere garantito, assicurato, controllato. La parola data non basta più. La fiducia nel prossimo non è ingenuità. È una costruzione fragile, che nasce dall’esperienza, dall’educazione, dall’esempio. Ma quando viene meno, la società si raffredda. Funziona, ma non vive. Diventa un insieme di individui protetti, non una comunità di persone responsabili.
Tecnologia e sospetto Anche la tecnologia ha un ruolo ambivalente in questa crisi della fiducia. Da un lato promette efficienza, trasparenza, controllo; dall’altro alimenta sorveglianza, manipolazione, dipendenza. Gli algoritmi decidono sempre più aspetti della nostra vita, ma restano opachi. Ci affidiamo a sistemi che non comprendiamo fino in fondo, e questa delega forzata produce inquietudine. La fiducia, per esistere, ha bisogno di comprensione. Quando i meccanismi che regolano il mondo diventano incomprensibili, la fiducia si trasforma in rassegnazione o in sospetto. E il sospetto è terreno fertile per le teorie del complotto, per il rifiuto della competenza, per la nostalgia di un passato più semplice – reale o immaginato.
Fiducia e memoria C’è un legame profondo tra fiducia e memoria. Le società che dimenticano il proprio passato sono più vulnerabili alla sfiducia, perché perdono i riferimenti, le lezioni, le responsabilità. La storia insegna che le grandi crisi di fiducia hanno spesso preceduto svolte autoritarie. Quando le persone smettono di credere nelle istituzioni democratiche, sono disposte ad accettare soluzioni drastiche. Ricordare non è un esercizio retorico, ma un atto politico. Serve a riconoscere errori, a evitare semplificazioni, a mantenere vivo il senso del limite. La fiducia non nasce dall’idea che “andrà tutto bene”, ma dalla consapevolezza che esistono anticorpi, che le regole contano, che le responsabilità non sono astratte.
La fiducia come compito Forse è per questo che “fiducia” è la parola del 2025 come compito collettivo. La fiducia non si impone per decreto, non si recupera con slogan rassicuranti. Si costruisce lentamente, attraverso comportamenti coerenti, istituzioni credibili, relazioni responsabili. Richiede tempo, pazienza, persino coraggio. Perché fidarsi, oggi, espone al rischio della delusione. Ma una società che rinuncia alla fiducia rinuncia anche alla possibilità di cambiare. Si chiude in una difesa permanente che alla lunga diventa sterile. La fiducia non è cieca. È vigile. Non ignora i conflitti, ma li attraversa. Non nega le crisi, ma rifiuta il cinismo come destino. È una scelta morale prima ancora che politica. In un mondo segnato da guerre, polarizzazioni e paure, ricostruire fiducia diventa vitale.