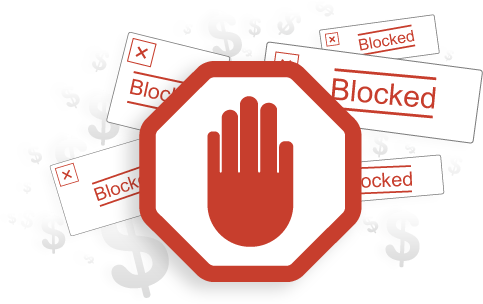Perché l’Olocausto riguarda anche chi è nato nel terzo millennio?
C’è una frase che ritorna spesso quando si parla di Shoah con i più giovani: «È una cosa terribile, ma è successa tanto tempo fa». Non è cinismo. È distanza. È il modo naturale in cui una generazione percepisce un evento che non ha toccato né i propri nonni né il proprio immaginario diretto.
Chi è nato dopo il 2000 è cresciuto in un mondo radicalmente diverso: internet, social network, crisi globali continue, guerre trasmesse in diretta, un flusso costante di immagini che rende tutto simultaneo e, paradossalmente, lontano. In questo contesto la Shoah rischia di diventare un capitolo chiuso del Novecento da ricordare per dovere. Ma è il contrario.
Parlare di Shoah alle nuove generazioni non significa attribuire colpe ereditate. La memoria non serve a condannare il passato, ma a decifrare il presente.
La Shoah è una chiave di lettura. Spiega cosa succede quando una società accetta che alcuni esseri umani valgano meno di altri. Quando la paura diventa strumento politico.
Se togliamo la Shoah dal nostro orizzonte, perdiamo la capacità di riconoscere certi segnali. E quei segnali, oggi, sono ovunque.
Il linguaggio dell’odio non nasce urlando. Nasce in modo più discreto. Inizia con le parole. Con le battute. Con le generalizzazioni.
“Quelli sono tutti uguali.”
“Ci stanno invadendo.”
“Non sono come noi.”
Sono frasi che circolano quotidianamente, online e offline. Ma il linguaggio non è mai neutro. Modella il modo in cui vediamo il mondo. Trasforma le persone in categorie. E le categorie sono sempre state il primo passo verso l’esclusione.
Prima si tolgono le parole, poi i diritti, poi le vite. Nessun genocidio comincia con le armi. Comincia con il vocabolario.
I social non hanno inventato l’odio, ma lo amplificano. I giovani di oggi vivono in uno spazio comunicativo senza precedenti. I social network non hanno creato l’odio, ma lo hanno reso più rapido, più visibile, più contagioso. Algoritmi che premiano lo scontro, contenuti estremi che generano interazioni, bolle informative che rafforzano convinzioni già esistenti.
In questo contesto la Shoah rischia una doppia distorsione: da un lato la banalizzazione, dall’altro la strumentalizzazione. Meme su Hitler, paragoni impropri, utilizzo superficiale di simboli e tragedie per attirare attenzione.
Non è solo cattivo gusto. È perdita di senso storico. Capire la Shoah oggi significa anche imparare a difendere la complessità in un mondo che premia la semplificazione.
Ricordare la Shoah non significa negare altri dolori. Significa riconoscere che quello sterminio ha caratteristiche specifiche: l’ideologia razziale, la volontà di annientamento totale, l’organizzazione industriale della morte. Non è una gara del dolore. È un’analisi storica.
Quando tutto viene messo sullo stesso piano, nulla viene davvero compreso. E quando la Shoah perde la sua specificità, perde anche la sua funzione educativa.
Molti giovani si sentono estranei a queste dinamiche perché non si percepiscono come razzisti o violenti. Ma la Shoah ci obbliga a fare una distinzione fondamentale: non basta non odiare per essere dalla parte giusta.
L’indifferenza è una scelta. Non intervenire, non informarsi, non prendere posizione significa lasciare spazio a chi urla più forte. Storicamente, è sempre stato così.
La maggior parte delle persone che vissero durante il nazismo non erano fanatici. Erano cittadini comuni. Ed è questo l’aspetto più inquietante: il male non ha bisogno di mostri, gli basta la passività.
Chi è nato dopo il 2000 è cresciuto in un’epoca di crisi continue: economiche, ambientali, sanitarie, geopolitiche. La sensazione di precarietà è costante. In questi contesti la ricerca di capri espiatori diventa una tentazione potente. Succede sempre nei momenti di paura.
La Shoah riguarda chi è nato dopo il 2000 perché è parte del patrimonio umano comune. Non è una storia “degli altri”. È una lezione universale sulla fragilità della civiltà. Chiede di essere capita. Usata come strumento critico.