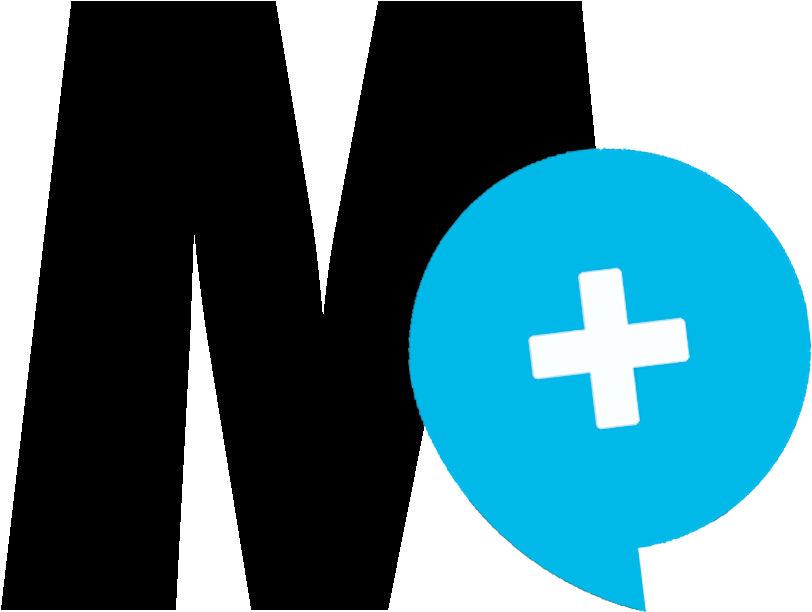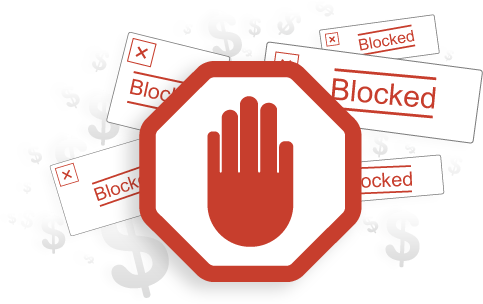L’algoritmo del sangue e l’esaltazione dell’ignoranza uccidono prima di una lama
L’ennesimo lenzuolo bianco steso in una periferia urbana, l’ennesima conta di un’anagrafe del dolore che non conosce sosta. Jlenia Musella, 22 anni non sarà l’ultima. Mentre l’eco della tragedia di Ponticelli scuote le coscienze, rischiamo di ritrovarci prigionieri del solito rituale stanco: accenderemo fiaccole, mostreremo scarpette rosse, osserveremo minuti di silenzio nelle scuole. Ma non basterà. E non è bastato quello che è stato fatto finora. Siamo dentro una prateria dove pascolano modelli culturali tossici che armano la mano degli energumeni di domani.
Continuiamo a parlare di prevenzione astratta ma abbiamo paura di affrontare il tema della repressione di certa cultura.
Guerra all’ignoranza
L’introduzione del reato specifico di femminicidio è stata una vittoria di civiltà giuridica, ma resta una risposta a valle di un fiume in piena. La legge arriva quando il sangue è già versato. Manca ancora un’azione forte contro la violenza che matura tra i giovanissimi. In certi contesti, il rispetto della legge è un concetto lontanissimo, quasi astratto; ciò che conta è il codice della strada, che impone il dominio fisico.
L’azione repressiva non può essere solo carceraria, ma deve essere sociale dove serve. Bisogna avere il coraggio di essere intolleranti nei confronti dell’ignoranza e della rozzezza intellettuale.
La violenza di genere, ma anche quella che divampa in ogni altra forma tra i ragazzi, non è un “errore di gioventù”, è spesso il risultato di analfabetismo civile che va stroncato con interventi punitivi e rieducativi immediati, senza il balbettio del garantismo a tutti i costi quando la minaccia è manifesta.
Se l’arte diventa istigazione
Se avessimo il coraggio di guardare nel baratro dei sub-modelli culturali, ci accorgeremmo che stiamo tollerando migliaia di esempi devastanti. Jlenia è stata uccisa per la musica troppo alta. E spesso in quella musica si nascondono i peggiori modelli di vita. Certa musica trap, per esempio. Smettiamola di considerarla una “forma d’arte” innocua, non lo è in contesti dove mancano gli strumenti per decodificarle. E smettiamola anche di nobilitarla come espressione anticonformista e rivoluzionaria facendo leva sull’ipocrisia intellettuale che difende tutto in nome della libertà d’espressione. Perché la libertà finisce dove inizia l’istigazione alla prevaricazione.
In quartieri come il Rione Conocal o nelle periferie degradate, se un ragazzino cresce ascoltando testi che riducono la donna a “trofeo” o a oggetto di proprietà, o guarda film e serie dove l’uomo forte è colui che usa la forza per farsi obbedire, quel ragazzino non diventerà un critico musicale o cinematografico: diventerà un prevaricatore.
Combattere i contenuti che esaltano la tossicità relazionale non può essere considerata una battaglia di oscurantismo, è difesa sociale. Non possiamo continuare a vendere “modelli criminali” come intrattenimento e poi stupirci se i nostri giovani li applicano nella vita reale.
I modelli femminili collusi
E c’è un altro discorso onesto sulla prevenzione che non può esimersi dal toccare un tasto dolente e spesso taciuto: la responsabilità di certi modelli femminili che accettano e magnificano la figura dell’uomo macho e prevaricatore. Nei contesti di marginalità, esiste una sottocultura che educa le ragazze ad accettare il malessere come prova d’amore, a vedere nella gelosia ossessiva e nella violenza del partner un segno di protezione o di passione. È tempo di condannare con forza quei modelli che esaltano la donna che sta accanto all’uomo violento, che ne giustifica le intemperanze in nome di una fedeltà arcaica e distorta. Se le giovani donne vengono bombardate da messaggi che dipingono il prevaricatore intellettualmente rozzo come il vero uomo, la battaglia è persa in partenza. Bisogna insegnare che un uomo che alza le mani, un ragazzo che sceglie di essere criminale, che impugna una pistola o un voltello, non è forte, è un miserabile residuo di un passato barbarico.
I social allevano i mostri
E molti di questi vegetano nei social network, che ci ostiniamo a considerare strumenti innocui e neutri. Non sono specchi, sono laboratori nei quali la violenza, l’ignoranza e la rozzezza non solo si alimenta ma trova la sua legittimazione definitiva. È in questi non-luogo che spesso sedimentano i comportamenti degli assassini di domani. Sui social assistiamo a una pericolosa alchimia: l’esaltazione dell’ego si fonde con una malvagità messa sfacciatamente in mostra, trasformando il narcisismo in una forma di potere effimero. Per ragazzi che vivono in contesti di privazione, la “fama” virtuale — fatta di visualizzazioni ottenute con sguardi truci o messaggi di sfida — è l’unica droga disponibile. Quella sensazione di onnipotenza scatenare la furia quando la realtà quotidiana non si piega ai loro desideri.
L’ipocrisia
L’errore più grave è l’ipocrisia con cui mascheriamo la nostra inerzia. In nome di una malintesa democrazia digitale, permettiamo che non esistano regole né censure reali contro chi magnifica la violenza. Ma dovremmo capire che la democrazia non può sopravvivere se accetta che il proprio spazio pubblico — oggi diventato digitale — sia occupato da chi nega il valore fondamentale della vita. Ecco la responsabilità più grande della società sana. Lascia crescere i mostri, nutre il loro egocentrismo con l’algoritmo, e poi si stupisce se il sangue continua a scorrere.