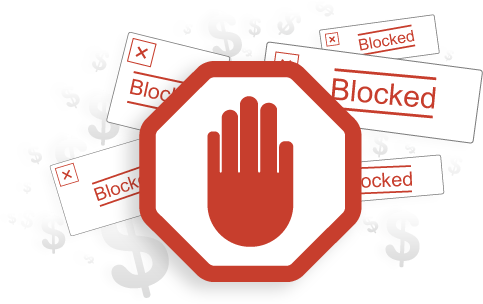Il caso Pucci e la gretta arena social. La pochezza di una società involuta
Il ritiro di Andrea Pucci dalla co-conduzione di Sanremo 2026 è l’ennesimo capitolo di una infima “querelle” politica tra destra e sinistra (della quale siamo stanchi). Ma è anche, molto più profondamente, il termometro di un Paese lacerato, la fotografia nitida di un’epoca che ha scambiato l’emancipazione digitale con un ritorno alle forme più barbare di giustizia sommaria.
Siamo scesi ai livelli più beceri del confronto. Quello che una volta era il dibattito pubblico, fatto di divergenze anche aspre ma pur sempre ancorate a un perimetro di civiltà, si è trasformato in un’arena permanente. Un’arena popolata, troppo spesso, da una folla che rivendica la libertà di essere gretta e rozza come se fosse un diritto costituzionale.
È il paradosso del nostro secolo: abbiamo abbattuto le barriere della comunicazione solo per scoprire che, senza il filtro dell’educazione e del rispetto, la piazza diventa un Colosseo di fango.
Il meccanismo è ormai tristemente noto. Non si contesta più un’idea, una battuta o una scelta professionale; si punta direttamente alla morte civile dell’avversario. Il “pollice verso” scatta immediato, alimentato da un algoritmo che premia l’insulto e punisce la sfumatura.
Quando un artista denuncia minacce alla propria famiglia e si vede costretto a rinunciare a un incarico pubblico, la sconfitta non è sua, ma di tutti noi. È il segno che il “patto fondamentale” tra chi parla e chi ascolta è saltato, sostituito da un clima di inquisizione dove i termini — fascismo, omofobia, razzismo — vengono usati come clave per annientare, non per comprendere o correggere.
La politica, dal canto suo, invece di ergersi a custode della temperanza, si tuffa nella mischia. Le reazioni immediate, da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, confermano che il livore è diventato la moneta corrente del consenso. Se da una parte c’è chi mette all’indice, dall’altra c’è chi cavalca l’indignazione, in un circolo vizioso che non lascia spazio alla riflessione, ma solo all’appartenenza tribale.
Abbiamo buttato via secoli di emancipazione per ritrovarci schiavi di uno schermo che ci autorizza a essere peggiori di come saremmo dal vivo. La democrazia è sacra, ma non può sopravvivere se la confondiamo con la licenza di aggredire.
Se il palcoscenico più importante d’Italia diventa un patibolo mediatico, significa che abbiamo smesso di essere una comunità di cittadini per diventare una massa di spettatori feroci, pronti a sbranare chiunque non si allinei al sentimento del momento.
Ripartire dai cocci di questo confronto significa anzitutto riconoscere che la libertà di parola non è nulla senza il dovere dell’ascolto. Di questo passo ci resterà solo il silenzio di un Paese che non sa più ridere, né discutere, ma solo odiare.