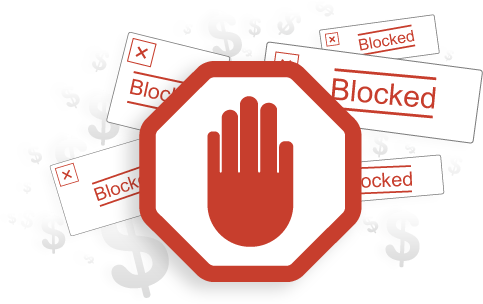L’ultimo gioco nella cattedrale del gelo. La storia di Domenico ci scopre più fragili
Domenico è entrato in ospedale stringendo i suoi giochi. Ne uscirà sigillato in una culla di legno bianco. Tra questi due istanti, separati da un abisso di dolore, non c’è stata la medicina, ma il naufragio di una civiltà che ha scambiato la tecnica con il destino. A due anni e mezzo, questo piccolo figlio di Nola non è più soltanto una vittima della sorte: è il martire di un’onnipotenza ferita, il testimone muto di un passo falso della scienza che ha consegnato il futuro al buio.
Mentre la tragedia si appresta a essere smembrata in fredda procedura giudiziaria, mentre i periti iniziano a sezionare colpe e protocolli come se la verità fosse un dato numerico, a noi resta addosso un brivido che nessuna perizia potrà placare. Abbiamo vissuto settimane in apnea, aggrappati all’illusione che la tecnologia potesse “resettare” il male, riparare quel corto circuito umano che ha trasformato un trapianto in una sentenza. Speravamo nel miracolo della macchina, in un colpo di spugna capace di cancellare l’orrore di un cuore spento, un pezzo di carne già arresa, eppure cucito nel petto di un innocente.
Un cuore di ghiaccio. Un organo che non poteva battere, impiantato perché diversamente non si poteva più fare. Una burocrazia che spaventa. Quel gelo non è rimasto confinato tra le piastrelle lucide della sala operatoria del Monaldi. Quel cuore di ghiaccio è oggi lo specchio oscuro di una società che sta smarrendo la capacità di fermarsi davanti al sacro perimetro del fragile. Siamo diventati infallibili nel misurare i parametri, ma restiamo ibernati di fronte allo strazio. Abbiamo costruito ospedali che somigliano a cattedrali tecnologiche, ma abbiamo dimenticato che senza l’umanità del dubbio, la tecnica può trasformarsi in un rito vuoto e, talvolta, feroce.
La storia di Domenico ci sbatte in faccia, con la violenza di un ritorno rimosso, il fantasma di Alfredino Rampi. Anche allora, nell’estate dell’Ottantuno, l’Italia s’illuse che i riflettori, le trivelle e la diretta televisiva potessero strappare un’anima al fango di Vermicino. Oggi, come allora, ne usciamo nudi. Scoperti. Ci credevamo invulnerabili nelle nostre vite iper-connesse, padroni del genoma e dei bit, e invece ci riscopriamo piccoli di fronte all’evidenza che tutto può finire in un soffio. Per un errore di calcolo. Per una mano che non ha potuto dire «fermiamoci» di fronte a un protocollo che verrà senz’altro stravolto.
Domenico non ha saputo nulla. Non ha udito il rumore dei consulti febbrili, non ha sentito il peso immenso che schiacciava il respiro dei suoi genitori. Fino a poco prima di Natale giocava nella sua stanzetta, abitando quel tempo sospeso dell’infanzia che doveva solo fiorire. È entrato al Monaldi per ricevere la vita e lo hanno infilato in un tunnel senza luce. La sua doveva essere la grande storia di Natale, il racconto di una resurrezione laica, è diventata una ferita che trapassa il cuore di un Paese intero.
Quando muore un bambino, non cade solo un individuo; crollano le fondamenta del senso stesso del vivere. Ci sentiamo derubati e, inevitabilmente, complici. Complici di un sistema che ha sostituito la cura con la procedura, la pietà con la statistica. Il pensiero corre ai piccoli che chiudono gli occhi troppo presto ovunque: per una diagnosi mancata o sotto il fuoco cinico delle guerre. Domenico è spirato tra i monitor più sofisticati, eppure la sua fine ci interroga allo stesso modo di una morte sotto le macerie di un bombardamento. In entrambi i casi, è l’adulto a fallire. La cecità della tecnica che sacrifica l’innocenza ha la stessa, identica temperatura del ghiaccio.
Ora arriveranno i tribunali. Si parlerà di sequestri, di responsabilità professionali, di bulloni da stringere in una burocrazia sanitaria rivelatasi fatale. È giusto, è necessario. Ma nessuna sentenza restituirà a Domenico i suoi giochi. Nessun risarcimento potrà scaldare il gelo calato per sempre sul cuore di sua madre.
Domenico ci lascia un’eredità pesante: il ricordo che la vita è un dono appeso a un filo sottilissimo, che nessuna macchina potrà mai garantire. La nostra onnipotenza è un’illusione che si frantuma davanti a una bara bianca. L’unica risposta possibile non è solo un protocollo diverso, ma il ritorno alla prossimità, al coraggio di restare umani. Dobbiamo impedire che il cinismo dell’abitudine e il nostro cuore di ghiaccio diventino la norma, mentre una vita, nel silenzio di una notte di febbraio, smette di lottare e ci lascia tutti un po’ più soli.